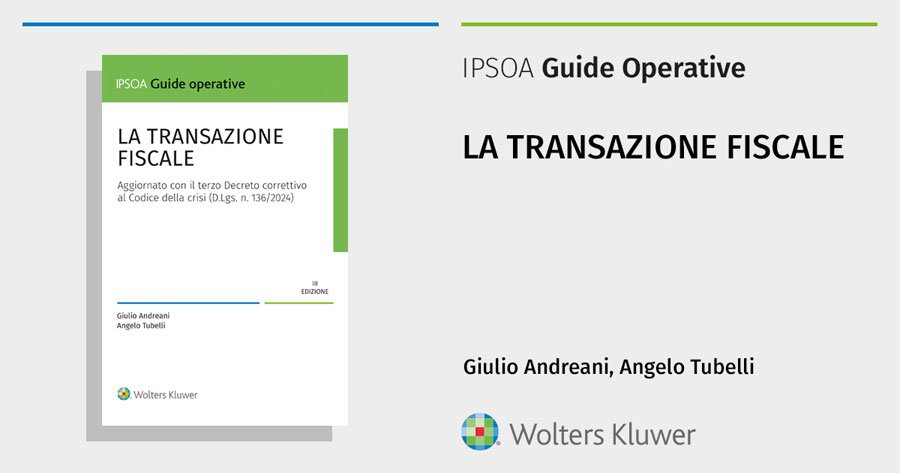di Giulio Andreani
La tesi dell’Agenzia non è condivisibile e conduce a risultati non convenienti per lo stesso Fisco, come si evince da alcuni casi concreti. Se l’intenzione era quella di trarre vantaggio per le casse dell’erario gli effetti sono per lo più deludenti quando non addirittura nulli. Vediamo perché.
L’articolo 182-ter, comma 1, legge fallimentare richiede all’attestatore di confrontare l’offerta formulata al Fisco mediante la proposta di transazione fiscale con il soddisfacimento che questi ricaverebbe alternativamente dalla liquidazione fallimentare dell’impresa debitrice.
Pertanto, per quantificare tale soddisfacimento, l’attestatore deve considerare la situazione che si verificherebbe in caso di fallimento del debitore, senza tener conto di scenari non realizzabili in tale circostanza, qual è quello della prosecuzione dell’attività attraverso modalità e interventi che sono attuabili nel concordato preventivo, ma non nel fallimento; a nulla rileva infatti che nella procedura fallimentare potrebbe aver corso l’esercizio provvisorio dell’impresa, perché si tratta di un fenomeno solo eventuale, per di più dipendente da provvedimenti degli organi giudiziali che non possono essere previsti, il quale in ogni caso ha finalità e produce effetti ben diversi da quelli derivanti da un concordato in continuità.
La situazione cui l’attestatore deve far riferimento è invece quella prevista dall’articolo 105 della legge fallimentare, che disciplina, appunto, la vendita dell’azienda nel suo complesso, dei suoi rami o, anche singolarmente, dei beni che la compongono, mediante procedure competitive. Posto che il valore economico, cioè di mercato, di un’azienda è costituito dal valore attuale dei suoi flussi finanziari o reddituali futuri (tranne che nel caso in cui esso risulti inferiore al prezzo realizzabile attraverso la vendita dei beni che la costituiscono, indipendentemente dal loro impiego strumentale), tale valore deve essere determinato dall’attestatore assumendo i flussi che l’azienda può generare nella situazione in cui questa si troverebbe in caso di fallimento, cioè escludendo quei flussi che potrebbero invece essere generati solo grazie al risanamento conseguibile con il concordato. Tra la prosecuzione dell’attività nell’ambito di un concordato e i flussi finanziari che ne discendono esiste infatti un evidente rapporto di causa-effetto, nel senso che questi non possono manifestarsi senza l’attuazione del risanamento oggetto del piano concordatario.
Per questi motivi, tali flussi e la componente di valore economico dell’azienda che da essi deriva non fanno parte del patrimonio del debitore nel caso in cui quest’ultimo venisse dichiarato fallito e non possono quindi concorrere a formare il valore di liquidazione da confrontare con quello offerto con la domanda di concordato e con la connessa transazione fiscale. È inoltre errato, sotto il profilo logico, valutare la bontà di una proposta di concordato comparandola con una situazione alternativa che non può realizzarsi senza l’attuazione di quella proposta.
Nulla precisa l’agenzia con riferimento all’accordo di ristrutturazione dei debiti, rispetto al quale il principio affermato nella circolare n. 16 non dovrebbe comunque trovare attuazione.